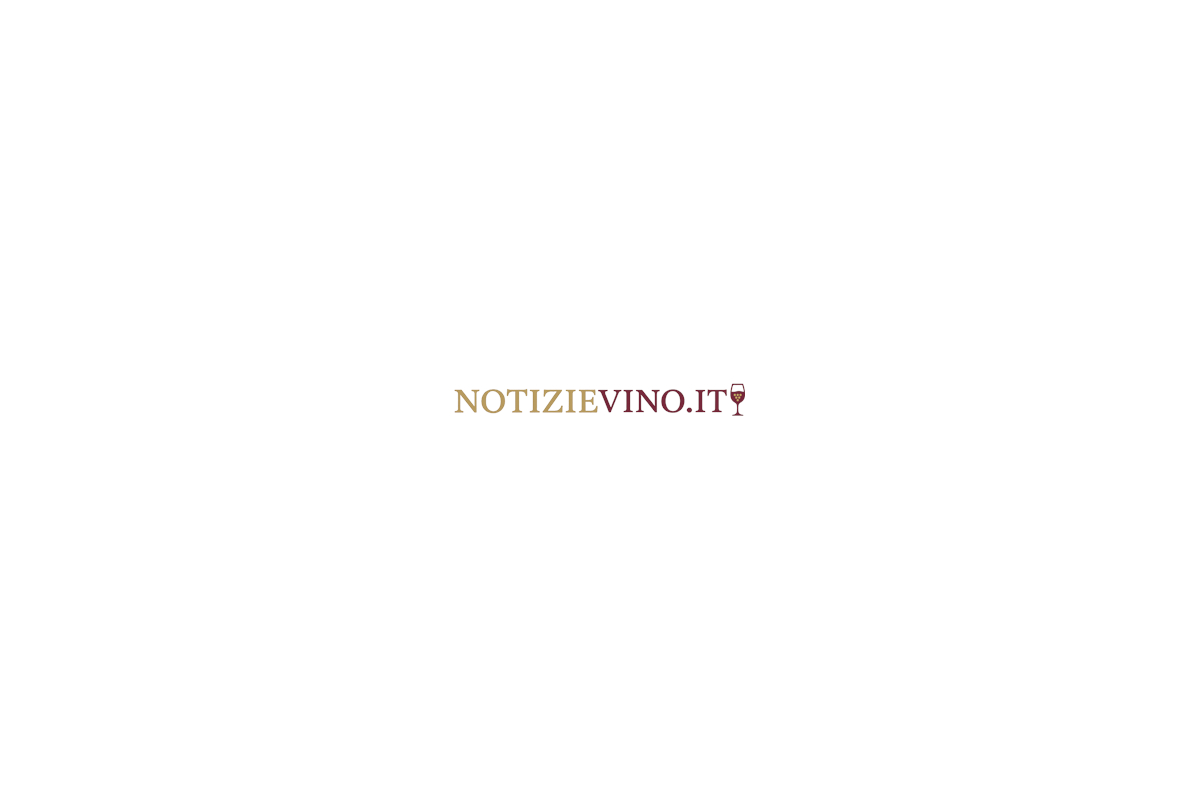La Falanghina rappresenta una delle testimonianze più autentiche della viticoltura dell’Italia meridionale, con radici che affondano profondamente nella storia antica della Campania. Questo vitigno a bacca bianca vanta origini che risalgono all’epoca romana, quando già veniva coltivato nelle fertili terre del Sannio e dell’Irpinia. Il nome stesso deriva dal latino “phalangae”, riferimento ai pali di sostegno utilizzati per le viti, evidenziando come questa varietà fosse già ben nota e apprezzata dagli antichi viticoltori.
Durante il periodo dell’Impero Romano, la Falanghina godeva di grande considerazione, tanto che Plinio il Vecchio la menzionava nelle sue opere come uno dei vini più pregiati della regione. Tuttavia, come molti vitigni autoctoni del Sud Italia, la Falanghina ha attraversato periodi di declino e riscoperta. Dopo secoli di coltivazione tradizionale, nel corso del Novecento ha rischiato l’estinzione a causa dell’abbandono delle campagne e della preferenza accordata a varietà più produttive ma meno caratteristiche.
La rinascita della Falanghina è iniziata negli anni Ottanta del secolo scorso, grazie all’impegno di alcuni produttori illuminati che hanno creduto nelle potenzialità di questo vitigno autoctono. Pionieri come la famiglia Mastroberardino hanno investito nella sua valorizzazione, contribuendo a riportarla all’attenzione del mondo enologico nazionale e internazionale.
Le varietà e i territori di elezione
La Falanghina si presenta in due biotipi principali che, pur condividendo il nome, mostrano caratteristiche distintive legate ai territori di coltivazione. La Falanghina dei Campi Flegrei, coltivata principalmente nella provincia di Napoli, si distingue per la sua mineralità vulcanica e la freschezza che deriva dai suoli ricchi di tufo e pozzolana. Questa varietà beneficia dell’influenza marina e del particolare microclima creato dall’attività vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei.
La Falanghina del Sannio, invece, trova la sua espressione più autentica nelle colline dell’entroterra beneventano, dove i terreni argillosi e calcarei conferiscono al vino una struttura più corposa e una complessità aromatica particolare. Questa zona, caratterizzata da un clima continentale mitigato dalla vicinanza al mare, offre condizioni ideali per una maturazione lenta e graduale delle uve.
Il terroir campano, con la sua straordinaria diversità geologica, permette alla Falanghina di esprimere sfumature diverse a seconda della zona di coltivazione. I suoli vulcanici donano mineralità e sapidità, mentre quelli calcarei contribuiscono all’eleganza e alla finezza del bouquet aromatico. L’altitudine, che varia dai 200 ai 600 metri sul livello del mare, influisce sulla freschezza e sull’acidità del vino, elementi fondamentali per la sua longevità.
Caratteristiche organolettiche e profilo sensoriale
La Falanghina si presenta con un colore giallo paglierino più o meno intenso, spesso con riflessi verdolini che testimoniano la sua freschezza. Al naso sviluppa un bouquet complesso e raffinato, caratterizzato da note floreali di ginestra e fiori bianchi, accompagnate da profumi fruttati di pesca, albicocca e agrumi. Con l’invecchiamento, il vino evolve verso sentori più maturi di frutta secca e miele, mantenendo sempre una piacevole vena minerale.
In bocca, la Falanghina si distingue per l’equilibrio tra freschezza e morbidezza, con un’acidità vivace che la rende particolarmente beverina e versatile nell’abbinamento con il cibo. La struttura è mediamente corposa, con una persistenza aromatica che richiama le sensazioni olfattive e lascia in bocca una piacevole sensazione sapida, eredità dei suoli di origine vulcanica.
La versatilità della Falanghina si manifesta anche nella capacità di adattarsi a diverse tecniche di vinificazione. Mentre la versione più tradizionale privilegia la freschezza e l’immediatezza, alcune interpretazioni più moderne prevedono l’affinamento in legno o sui lieviti, che conferiscono maggiore complessità e struttura al vino, rendendolo adatto anche a un invecchiamento di medio periodo.
Abbinamenti gastronomici e tradizione culinaria
La Falanghina trova la sua espressione più autentica nell’abbinamento con la cucina campana, di cui rappresenta il compagno ideale. La sua freschezza e sapidità si sposano perfettamente con i piatti a base di pesce e frutti di mare, dalle classiche linguine alle vongole fino ai più elaborati crudi di ricciola e tonno. La tradizione vuole che sia il vino perfetto per accompagnare la mozzarella di bufala campana, creando un connubio di sapori che esalta le caratteristiche di entrambi i prodotti.
Non mancano gli abbinamenti con primi piatti della tradizione, come la pasta e fagioli, la pasta con le zucchine o i classici spaghetti al pomodoro e basilico. La versatilità della Falanghina la rende adatta anche ad antipasti a base di verdure, formaggi freschi e salumi delicati. Nelle versioni più strutturate, può accompagnare anche carni bianche e piatti di media intensità, dimostrando una flessibilità che la rende un vino da tutto pasto.
Curiosità e aneddoti
Una delle curiosità più affascinanti legate alla Falanghina riguarda la sua resistenza alle avversità climatiche e alle malattie della vite. Questo vitigno ha dimostrato nel corso dei secoli una straordinaria capacità di adattamento, sopravvivendo a periodi difficili grazie alla sua rusticità e alla dedizione dei viticoltori locali che ne hanno preservato il patrimonio genetico.
Un aneddoto interessante racconta che durante il periodo borbonico, la Falanghina veniva servita alla corte di Napoli durante i banchetti ufficiali, considerata un simbolo dell’eccellenza enologica del Regno delle Due Sicilie. Questa tradizione nobiliare ha contribuito a mantenere viva la reputazione del vitigno anche durante i periodi più bui della sua storia.
Oggi la Falanghina sta vivendo un momento di grande rinascita, con un numero crescente di produttori che investono nella sua coltivazione e vinificazione. Il riconoscimento delle denominazioni DOC e DOCG ha contribuito a valorizzare questo patrimonio enologico, garantendo standard qualitativi elevati e promuovendo la conoscenza del vitigno anche sui mercati internazionali. La Falanghina rappresenta così un perfetto esempio di come la tradizione possa incontrare l’innovazione, mantenendo intatta la propria identità territoriale mentre si apre a nuove interpretazioni enologiche.